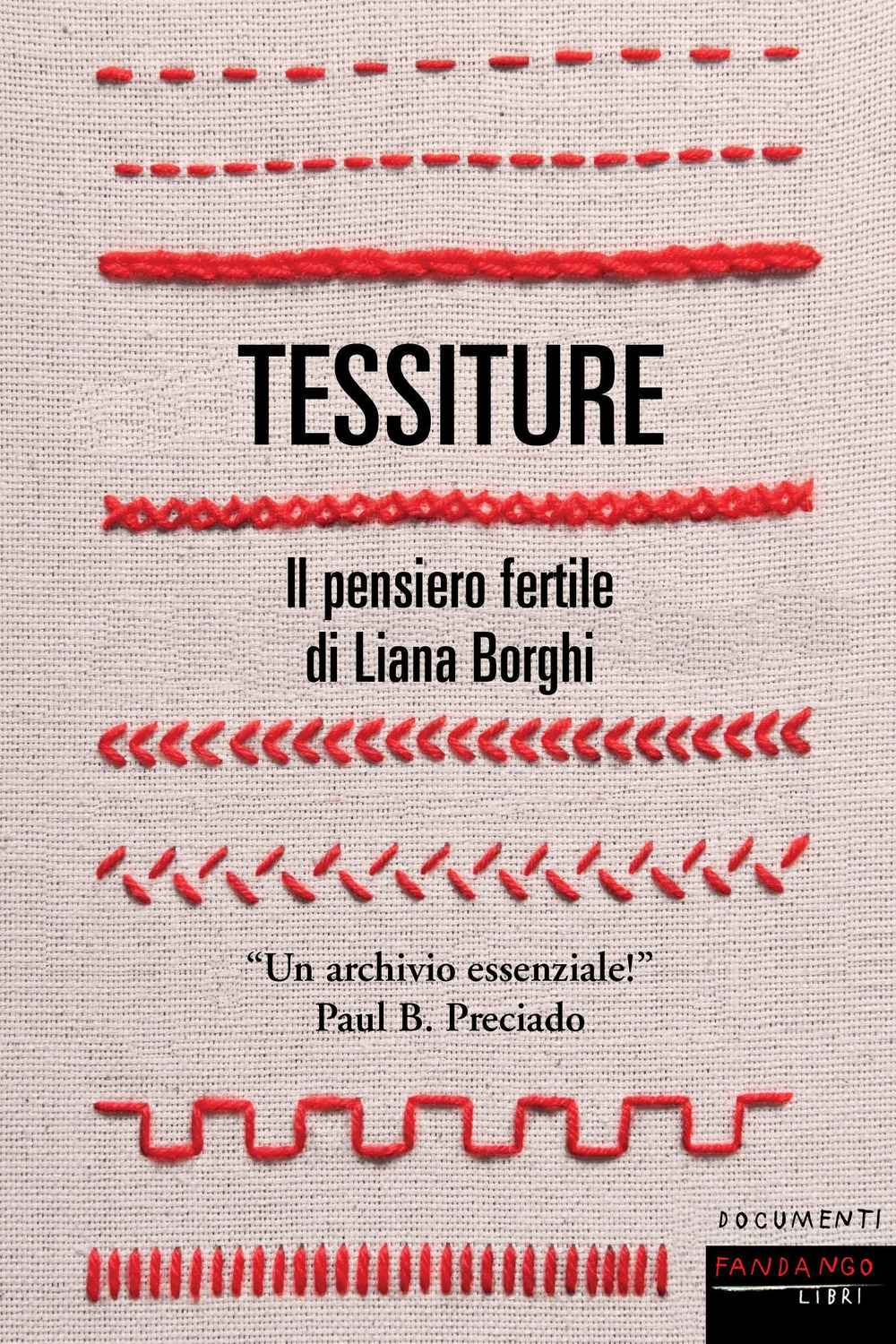AFFETTI, tecnologie, performatività : gli attraversamenti disciplinari di Liana Borghi di Federica Frabetti (University of Roehampton)
Il mio intervento si intitola “Affetti, tecnologie, performatività̀: gli attraversamenti disciplinari di Liana Borghi”. Questo perché la mia intenzione era di fare un intervento per benino; e se leggete il titolo del mio contributo a Tessiture (“Incanto Queer”), quello è un titolo po’ più fantasioso, però si tratta sempre di un intervento per benino.1 E’ un intervento che ha uno stile accademico forse un po’ fuori moda – è quasi un’involontaria parodia. Gli interventi per benino servono tipicamente a chi viene valutato da una istituzione accademica e si deve muovere in un quadro concettuale appropriato. In questi giorni però sono stata molto arrabbiata per quello che è successo nel Regno Unito, dove vivo, dopo che ho consegnato a Clotilde il mio titolo per benino e ho deciso di riflettere questa rabbia nel mio intervento, perché penso che un ricordo amoroso di Liana non possa scindersi, proprio diffrattivamente, da una chiamata all’azione.
Userò comunque le tre parole del titolo (tecnologie, performatività e affetti – e naturalmente gli attraversamenti di contesti e saperi di cui Liana era maestra) perché hanno significato moltissimo nella mappa concettuale del mio rapporto con Liana (per usare un concetto che viene dalla praxis della Scuola Estiva di Villa Fiorelli). Ci dovrebbe essere una quarta parola chiave, ma forse la possiamo includere sotto “performatività” e riconoscerne la parentela con “diffrazione”: la quarta parola è “frammentazione”, e il mio intervento sarà un po’ frammentario, perché la realtà ha fatto irruzione nella mia scrittura e nelle mie pratiche con tale violenza in questi ultimi tempi che non mi è stato possibile scrivere in altro modo. E poi la sistematicità, lo sappiamo, non è nemmeno più un modo possibile del pensiero-azione, come il lavoro di tessitura molteplice e di intramazione di Liana ci dimostra bene; non è un modo
1 Tessiture. Il pensiero fertile di Liana Borghi, Roma: Fandango, 2022. 1
praticabile di affrontare il presente e la frenesia e la violenza del sistema di sapere- potere neoliberista. Se si viene da settimane di alternanza tra scioperi, picchetti, malattia, e superlavoro, si finisce per essere un po’ frammentate.
Riprenderò anche alcune linee che ci sono nell’intervento per Tessiture, ma le porterò altrove. Per riprendere, appunto, Tessiture, Liana ha cominciato un intervento al Prado di Madrid nel 2014 proprio così, con una frase che per me sintetizza il suo lavoro teorico/politico. La frase di Liana è “Sto per portarvi altrove”2. L’intervento del Prado si colloca nel contesto del primo forum di Metabody, una rete collaborativa triennale gestita da Jaime del Val e finanziata da fondi di ricerca europei che coinvolge collettivi artistici, laboratori di ricerca e attivisti.3 Metabody intende ripensare percezione, movimento, cognizioni e affetti al di fuori della concezione cartesiana fondata sulla dualità corpo-mente. L’obiettivo è indagare come cognizioni e affetti siano processi relazionali e corporei multiformi e quindi irriducibili a significati normativi. L’obiettivo è anche fondare una diversità culturale sostenibile su forme di gestualità e movimento che eccedono categorizzazioni predefinite. Il titolo dell’intervento di Liana è “Spettralizzare il queer” (“Ghosting the queer”) e Liana apre questo intervento rivolgendosi all’uditorio vario e informale che affolla la saletta del Medialab con la frase, appunto, “Sto per portarvi altrove”.
In questo intervento, Liana fa un’operazione molto complessa e insieme molto semplice: reintroduce il queer in un contesto che l’ha dimenticato. La sera precedente, tornando in albergo, Liana mi ha chiesto “ma in questo progetto dov’è il queer?”. E’ una domanda che Liana ripeterà spesso, per anni, in contesti diversi, sia accademici che attivistici; soprattutto in quei contesti che ho scoperto grazie a lei, dove si produce sapere teorico vero (già quando questo sapere nelle università non c’era ancora, o c’era poco, per lo meno in Italia), cioè sapere a stretto contatto con le pratiche di movimento. E’ grazie a Liana, è grazie a questa realtà, che io scopro intorno al 2003 che in Italia c’è ancora chi pensa, e pensa davvero – io che venivo sia da un mondo universitario che sentivo non pienamente corrispondente ai miei desideri sia dal
2 L. Borghi, Ghosting the Queer. Presentato a “Multiplicities in Motion: Affects, Embodiments and the Reversal of Cybernetics” First Metabody Forum, Madrid, 24-31 luglio 2013. https://www.youtube.com/watch?v=gtrsQ0Y7DTI.
3 Metabody (s.d.), Introduction. https://metabody.eu.
2
grassroot activism del Social Forum, dalla politica semi-istituzionale dei comitati di base della FIOM e da gruppi partitici (Rifondazione Comunista) e interpartitici (come quello di Milano del 1999 sulla guerra in Kosovo), dove si produceva azione ma, dal mio punto di vista, non abbastanza pensiero. “Il queer” non era solo un modo abbreviato per riferirsi agli studi queer di matrice angloamericana che conosciamo e a pratiche politiche che aprivano a posizionalità e soggettività non lesbo-gay mainstream. Chiedere “dov’è il queer?” era uno dei modi scelti da Liana per interrogare le nostre pratiche e saperi, per ricordarci che siamo corpi, per invitarci a riposizionarci e a risituarci (per usare un termine di Haraway). Era un invito a rendere esplicito il taglio epistemontologico, l’intra-azione (per usare termini mutuati da Karen Barad, come spiegherò dopo) costituita dalla nostra presa di parola. Non era mai una critica; era piuttosto una suggestione creativa, che poneva l’elemento queer come quell’entità materialsociale, naturculturale, in continua trasformazione, che ci invita a disimparare le pratiche e le teorie dominanti e a intessere rapporti nuovi tra saperi, soggettività, corpi, specie, e oggetti.
Soprattutto, la domanda “dov’è il queer?” sintetizza la capacità di Liana di reintrodurre sempre, in qualsiasi contesto, in qualsiasi sapere, in qualsiasi campo più o meno istituzionalizzato, qualcosa che viene da un altro contesto. Sintetizza la sua capacità di richiamarci al dare conto di sé e di compiere attraversamenti che sono anche elementi di disturbo e destabilizzazioni di confini
La frase che dovrebbe aprire il mio intervento, come produttiva diffrazione del suo, è “Sto per deludervi”.
Sto per deludervi come penso di avere deluso lei, perché Liana aveva una grande capacità di farci sentire viste, significanti e significative, ma anche di stimolarci appunto ad andare oltre, e questo spesso mi ha fatto sentire “non abbastanza”: non abbastanza queer, non abbastanza politica, non abbastanza dentro le cose, non abbastanza fuori dalle cose, non sono andata abbastanza lontano, non sono rimasta abbastanza vicino – non abbastanza. Si tratta però di un “non abbastanza” abilitante, non disabilitante; empowering, non disempowering; una delusione positiva, rinforzante, che mi/ci ricorda che c’è ancora da fare e che possiamo farlo; forse assomiglia un po’ alla “queer art of failure” di Jack Halberstam, il fallimento produttivo
3
di chi come noi si ritrova qui a chiedersi che cosa si può fare, ancora e oltre.4 Sto per deludervi, e spero che questo ci porti altrove.
Cercherò di parlare al presente e al futuro. Se parlo al passato, è uno sbaglio – perdonatemi. Parlerò al presente e al futuro perché, nonostante e con Lee Edelman, penso che si debba continuare un lavoro che ci porti fuori dalle futurità etero e omo- normative di trasmissione riproduttiva e patrimoniale (e sottolineo patrimoniale); perché nemmeno per un momento voglio pensare che con Liana finisca qualcosa. Con Liana, lo dico per esperienza, comincia sempre qualcosa.
Circa due mesi dopo che Liana ha abbandonato questa piega spaziotemporale in cui ci troviamo in questo momento onto-epistemologicamente insieme (ancora Barad), un lutto ancora più grande mi ha colpita e ha cambiato la mia vita per sempre. Questo lutto irrimediabile mi ha insegnato moltissime cose, tra cui il senso della presenza di chi sembra essere andata via senza potersene andare mai davvero. Una delle cose che ho imparato è che, per quanto possa sembrare controintuitivo, non c’è in realtà un lutto più grande di un altro. Quando un lutto “più grande” mi colpisce, per me è come se entrambi i lutti si potenziassero a vicenda, e ognuno diventasse, in virtù dell’altro, un po’ più grande. E’ una più grande assenza, una più forte presenza, una più forte spinta a vivere – un vitalismo buono, innamorato del vivente e dell’inorganico come in Ortese e LeGuin di cui Monica Farnetti ha scritto così bene.5
Ancora un caveat: quando una cosa “non mi funziona”, lo dico (e uso qui il linguaggio tagliente di Francesca Manieri, perché la diffrazione non riguarda solo Liana; vorrei diffrangere un po’ tutte).6 Ci sono tante cose che non mi funzionano con Liana e tante altre che mi funzionano benissimo. Il coming out di classe è una di quelle cose che mi funzionano poco, e Liana lo sa. Spiego anche questo tra un attimo.
Gli attraversamenti e l’andare altrove cominciano presto, per me, con Liana. Una delle prime cose che lei mi chiede di scrivere è una voce sul “Postumano” per una collezione edita da Meltemi, che esce nel 2004, curata da Michele Cometa, che si intitola Dizionario degli studi culturali. Mi dice, “ho troppo da fare, ti va di farlo tu?” – a me, che prima di tutto non so che cosa siano gli studi culturali, e secondo non ho affiliazioni di
4 J. Halberstam, The Queer Art of Failure, Duke University Press, Durham, NC, 2011.
5 Basti pensare al bellissimo contributo di Monica Farnetti per Tessiture (“L(’)i(gu)ana“, pp.102-113.) 6 Ancora in Tessiture, pp.124-129.
4
nessun tipo, meno che mai accademiche. E, con quello che scoprirò poi essere una delle sue modalità tipiche, mi mette tra le braccia questa possibilità abilitante, potenziante, empowering, con l’aria grata di chi riceve – lei, da me – un favore. Fast- forward sei mesi dopo, e mi ritrovo ad avere un’affiliazione accademica proprio nel campo degli studi culturali, perché ho deciso di usare i miei risparmi di una precedente vita lavorativa per autofinanziarmi un master e poi un dottorato a Goldsmiths, Londra. Tutta colpa di Liana, che mi ha fatto la sua dichiarazione performativa abilitante. “Ce la puoi fare”, mi dice. E io lo faccio.
Faccio un veloce excursus a proposito dell’imperialismo culturale angloamericano, che è stato messo troppe volte in relazione con i queer studies, e dal quale Liana, nonostante o forse proprio a causa della sua formazione anglistica, si teneva ben lontana. Scrivendo del postumano, mando la prima traccia a Liana e dico, tremebonda, “Come ti sembra?” Lei mi risponde: “Sì, Federica, va abbastanza bene, ma c’è un grosso problema. Ti hanno chiesto anche una bibliografia, e nella bibliografia tu citi solo fonti angloamericane. Non va bene. Ci devi mettere altro, cara”.
Ritorno al “ce la puoi fare”. Faccio, e mi ritrovo a Goldsmith, Dipartimento di Media and Communications, che però si può considerare un dipartimento di studi dei media e studi culturali (in dialogo, allora, col parallelo Centre for Cultural Studies). Questo è importante non perché è la mia storia, che qui si ferma perché non interessa in questo dibattito, ma per tre motivi, che tutti afferiscono a Liana. Numero uno: cultural studies non è queer studies ma è “accanto” a queer studies – dentro e fuori, in una specie di intersecazione dinamica, ed è un campo che vuole essere anche dentro e fuori l’istituzione accademica, se mai è possibile, senza essere incorporato e cooptato in essa. Numero due: gli studi culturali sono un campo in decostruzione (e il pensiero di Liana è almeno in parte decostruzionista, lo voglio ricordare). Numero tre: cultural studies oggi è “in rovine”7.
Comincio dal primo punto. Cultural Studies non è propriamente queer studies. E’ e non è. In quel particolare dipartimento di Goldsmiths, nei primi anni Duemila, ci sono figure che Liana amerà poi molto: Luciana Parisi e Sara Ahmed, per fare qualche esempio – femministe importanti, teoriche importanti, che intraprenderanno azioni
7 Ho in mente qui il titolo del famoso testo di Bill Readings The University in Ruins (Harvard University Press, 1996), che ha acquisito un nuovo significato con gli sviluppi dell’università neoliberista angloamericana dell’ultimo ventennio.
5
politiche importanti (Ahmed) o che sono state dentro gruppi politici e teorici radicali, insieme a persone come Mark Fisher. Studi culturali significa “stare accanto” a queer studies, e “stare accanto” significa amare, amare molto, significa rispettare, ma significa anche spesso trovarsi in difficoltà. Così Liana comincia a rivolgere a me questa domanda, sempre più spesso. “Sì, ma qui dov’è il queer?” Certe cose che faccio non sono abbastanza queer. Il mio primo libro, ne sono certa, non è abbastanza queer. Lei non me lo dice proprio chiaramente, ma secondo me è un po’ delusa. Lo stare accanto ci espone a delusioni.
Faccio un passo indietro sul titolo di questo sconnesso intervento, così avanzo anche un punto – oserei dire – quasi programmatico. Quando mi ha chiesto (forse incautamente) questo contributo, Clotilde mi ha ricordato un mio intervento di anni fa su oggetti, tecnologia e affettività che le era piaciuto. Non eravamo sicure né io né lei, ma penso si riferisse a un contributo intitolato “Oggetti del sapere nell’università globale” presentato nel 2011 a Duino, a quella che era diventata la nuova versione della Scuola Estiva “Raccontar(si)” dopo Villa Fiorelli. Se si tratta di quello, ricordo che arrivai a Duino trafelata, e fallii completamente il tema del convegno, perché presentai una riflessione su che cosa contasse come oggetto del sapere nell’università che si stava neoliberalizzando e globalizzando – in quella che sembra una fotografia d’epoca, a riguardarla adesso, undici anni dopo – mentre Liana, in quegli anni, stava ragionando di archeologia degli affetti, relazioni affettive con l’inanimato, Cvetkovic, corpi migranti, spazi pubblici e scarpe. L’intervento, inaspettatamente, piace a Liana, che ci trova delle assonanze con quello che sta facendo. Perché con lei è sempre così, e questo è importante ricordarlo. Io porto ciò su cui sto lavorando, e poi ci pensa lei a dargli un senso. O meglio, ci pensa lei e, con lei, ci pensiamo tutte. Il punto programmatico è questo. Liana adesso non può più dare un senso ai miei e nostri frammenti come faceva prima. Però lo farà, io credo, in altro modo. Attraverso di noi e con noi. Bisogna che mettiamo in mezzo, o che “buttiamo dentro”, tutto: le nostre idee che non sono mai distinte dal vissuto e le nostre pratiche che sono sempre già pensiero – perché è questa inseparabilità di teoria e pratica che contraddistingue e ha sempre contraddistinto i nostri movimenti. Buttiamo dentro tutto, buttiamo in mezzo tutto, ed è solo così che si lavora davvero. “Buttare” non significa “buttare lì”. Significa offrire. Io vorrei cominciare con l’offrire uno statement quasi assiomatico che mi è venuto qualche giorno fa: le idee vengono sempre alle altre, mai a noi (oppure: vengono
6
sempre all’altra, mai a me). Questo l’ho imparato insegnando e anche attraverso pratiche di scrittura collaborativa. Liana si fida (assurdamente) di me, si fida di noi, perché sa che funziona così. Un’idea cresce solo se le soggettività e le collettività la prendono and they run with it (uso un anglicismo): l’accettano, se ne assumono la responsabilità e la adoperano; letteralmente: con quell’idea corrono. Liana ci regala sapere ma non ci fa una concessione – forse è questa la caratteristica distintiva della sua generosità. Ci chiede di vivere le cose che lei traspone per noi. Di farne qualcosa. Di non lasciarle lettera morta, per favore, grazie.
Questo è il primo punto: Stare accanto. Salto ora al terzo punto; poi tornerò al secondo. Il primo punto riguardava i radicali, politici, attivistici studi culturali e queer dei primi anni Duemila. Anni entusiasmanti. Ecco dove sono, ecco dove siamo ora. Ho alcune foto:
7
Questo è il dipartimento di Arts and Humanities di una università del Regno Unito che non nominerò. Vedete come si presenta? Corridoi vuoti, uffici deserti, nomi di colleghi che se ne sono andati letteralmente divelti da porte e muri. Qui c’era letteratura angloamericana; qui invece c’era un dipartimento di arti performative al top della REF
8
20218, con un bellissimo gruppo di lavoro sull’embodiment queer. “Dov’è il queer?”, mi chiedeva Liana. Ecco dov’è il queer adesso.
L’università neoliberale britannica non richiede solo un’analisi intersezionale (ad esempio, di come il gap retributivo colpisca donne e BAME9 a fronte della retribuzione più elevata dei maschi bianchi). E’ anche importante fare un’analisi di classe, perché queste fotografie e queste politiche governative ci dicono che il diritto alle arts and humanities, visto come “sapere fine a se stesso” e il diritto alla teoria e alla critica sono diritti di élite, per chi frequenta università di élite; pensare è diritto delle élite economiche che hanno accesso a scuole secondarie private, le quali forniscono la più alta percentuale di studenti alle università di élite. La percentuale di studenti BAME nelle università di élite è bassa ma superiore a quella degli studenti provenienti da zone di “disagio socioeconomico”.10 Ciò si applica anche agli insegnanti universitari, specie in una congiuntura storica in cui le università britanniche si stanno dichiarando in massa “in rosso” e considerano i tagli alle arts and humanities la via più breve verso la quadratura del bilancio.11 Le ragioni, squisitamente economiche, impattano fortemente quella che in tempi molto antichi si sarebbe chiamata autodeterminazione femminile: se non si è parte di una coppia (gay o etero) con qualcuno che abbia a sua volta uno stipendio non si può sopravvivere. Se si vuole intraprendere la professione accademica, è una buona idea anche poter contare su un cospicuo patrimonio familiare. Altrimenti, l’accademica single (queer e non) si colloca facilmente sotto la soglia di povertà, specie se consideriamo la retribuzione oraria. Quando studiavo, nei primi anni Duemila, i miei insegnanti non lavoravano settimane di 50, 60, 70 ore, senza serate libere, senza weekend, senza tempi di riposo, senza ferie. A poco più di un decennio di distanza, il nostro salario ha perso il 20% del suo potere di acquisto mentre il carico di lavoro è fortemente aumentato. Normalmente oggi un* accademic* con un impiego stabile lavora l’equivalente di due giorni lavorativi non pagati a settimana
8 REF (Research Excellence Framework), esercizio quinquennale di valutazione della ricerca a livello nazionale.
9 Black and Ethnic Minorities.
10 Nel 2022 un rapporto ufficiale dell’università di Oxford dichiara che la percentuale di studenti che si identificano come BAME è salita dal 18% al 25% e quella degli studenti provenienti da zone disagiate dal punto di vista socioeconomico dall’11% al 17% (University of Oxford Annual Admissions Statistical Report, 2022 https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/AnnualAdmissionsStatisticalReport2022.pdf).
11 R. Clare, How Working-Class Academics Are Set Up to Fail, The Tribune, 2020, https://tribunemag.co.uk/2020/10/how-working-class-academics-are-set-up-to-fail. Si veda anche il sito della AWCA (Alliance of Working Class Academics), https://www.workingclassacademics.com/news.
9
(circa 16 ore); la forza lavoro casualizzata lavora non pagata quattro giorni su cinque.12 La pratica del “fire and rehire” è sempre più diffusa e ha in certo modo precarizzato anche i contratti a tempo indeterminato.13 L’anno scorso sono stata in malattia dieci mesi per ansia, depressione e cardiopatia da stress. Metà della forza lavoro nelle università britanniche ha sintomi di depressione (le percentuali variano da istituzione a istituzione e possono essere anche molto più alte); siamo sottodimensionati, bullizzati e facciamo parte di uno dei settori professionali qualificati ad alto rischio di suicidio (preceduti dagli insegnanti di scuola primaria e secondaria e dal personale sanitario, soprattutto dalle infermiere).14
Due giorni fa, giovedì 30 novembre 2022, c’è stato il più grande sciopero nazionale della storia nel settore universitario. A dire la verità, l’interno Regno Unito è in sciopero: trasporti, poste, infermieri, autisti di ambulanze, insegnanti. Il tasso di persone homeless “visibili” (quelle che dormono per strada, che sono la punta di un iceberg) è più che raddoppiato dal 2010. E’ sempre stato così: “Tories back in office, people back on the street”, i conservatori al governo, la gente sulla strada.
Personalmente, porto sul corpo i segni della violenza del sistema neoliberista. Sono piena di farmaci e la mia aspettativa di vita si è accorciata.
Ho bisogno che il movimento queer faccia coming out di classe – cosa che forse non siamo state tanto propense a fare in questi anni. Ho bisogno che la dichiarazione di privilegio (“sono una soggetta bianca privilegiata in quanto docente universitaria con posizione di lavoro stabile”) sia declinata in molte più sfumature di quelle che usiamo al momento, che in inglese si direbbero “perfunctory”, una forma di “paying lip service”, una specie di “mettersi la coscienza a posto”. Non siamo più negli anni Ottanta, e se all’epoca Donna Haraway poteva dichiararsi middle class in quanto accademica, oggi le cose sono cambiate. Io non mi sento né mi sono mai sentita middle class, ma anzi working class (borderline under-class se dovessi perdere i lavoro). “Dov’è il queer?”
12 T. Williams, Lowest paid in academia work four days for free every week, Times Higher Education, 20.06.2022, https://www.timeshighereducation.com/news/lowest-paid-academia-work-four-days-free- every-week
13 “Fire and rehire” è il processo per cui si viene prima messi in esubero e poi ci si deve ricandidare alla propria posizione di lavoro e si è riassunti a condizioni peggiori.
14 A. Oswald, Middle-aged academics are at greater suicide risk than students, Times Higher Education, giugno 2018; M. Martin, Rise in teachers ‘at risk of suicide’, TES Magazine, 20 ottobre 2022.
10
mi chiede dunque in questi anni Liana – e io le rispondo invariabilmente: “Liana, se non accetto di smettere di pubblicare per fare invece il controllo qualità di un corso di laurea in informatica dato in outsourcing a un’azienda privata, mi licenziano”. Ecco dov’è il queer.
Gli studi culturali sono un campo disciplinare che ha seguito un percorso simile ai queer studies e nello stesso tempo inverso. E’ un campo britannico, non americano (diciamo, semplificando, che i cultural studies negli Stati Uniti hanno una storia molto diversa). E’ un campo nato nel secondo dopoguerra per opera di alcuni studiosi di letteratura inglese maschi, bianchi, marxisti. In parole semplici, i cultural studies partono della semplice premessa che l’ università è un luogo di oppressione, un dispositivo di repressione e di mantenimento dello status quo. Cultural studies ,come campo disciplinare, ha sostituito Shakespeare con le soap opera e ha dichiarato che la cultura della classe operaia ha lo stesso valore della cultura letteraria “alta”. Ci sono volute alcune generazioni per svegliare questi maschi bianchi sulle problematiche di razza e genere.15 In compenso, i cultural studies mi hanno abilitata a parlare di classe in un modo che non avevo mai conosciuto prima.
Dov’è il queer? Il queer è un movimento interclassista? (Istintivamente suggerisco di rispondere: no, almeno finché non farà della classe un’analisi esplicita). Il queer e’ un movimento class-blind, che non vede la classe e forse si rifiuta di vederla? (Suggerimento: forse, e bisogna fare attenzione). Personalmente ho un grande bisogno che i movimenti che si riconoscono in qualche modo nel queer prestino più attenzione al coming out di classe, in Italia e in altri paesi. Brutalmente: molte delle persone con cui faccio attivismo di base (grassroot activism) in altri campi in Italia e all’estero, so di che cosa vivono. Nei contesti queer ne sono meno sicura.
Ho bisogno di stare dentro a diversi movimenti e forme di attivismo di base, anche non queer. Per esempio, ho bisogno di stare dentro a un gruppo di ricerca e attivismo che si occupa di medicina di prossimità come parte della campagna internazionale “Primary Healthcare: Now or Never”, contestualizzato in un quartiere periferico di una
15 E. Probyn, A Feminist Love Letter to Stuart Hall; or What Feminist Cultural Studies Needs to Remember, Cultural Studies Review, 22(1), 2016 https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/article/view/4919/5420
11
piccola città italiana, e sto mettendo a loro disposizione le mie competenze di socio- antropologia e la mia esperienza di cittadina che ha fatto da carer per anni.16 Ho bisogno di stare dentro a tante realtà perché so che cosa vuol dire la privatizzazione del sistema sanitario, lo provo sulla mia pelle da vent’anni e ne porto, appunto, i segni. Voglio difendere il sistema italiano perché non diventi mai come quello britannico. E ho bisogno di tenere insieme queste tensioni.
Ho bisogno che teniamo a mente, come movimenti, che tanto c’è sempre violenza, la materia è performativa e dunque sempre escludente (ancora Barad); ogni volta che si materializza, essa opera un taglio epistemontologico, una esclusione, e questa non è solo una bella figurazione, ma una ferita.
Ho bisogno che ragioniamo non solo sull’ottimismo della volontà (affiancato dal pessimismo della ragione) e sull’utopia ma anche sul “cruel optimism” di Lauren Berlant, che Liana conosce così bene. Perché queer non diventi mai, nemmeno involontariamente, una forma di ottimismo crudele. Sono sicura che Liana di queste cose ha parlato, ma negli ultimi tempi io ero troppo sotto la linea dell’orizzonte per mantenere i contatti con lei in modo adeguato. Vorrei recuperarle, penso che siano importanti.
Oltre al primo e al terzo punto, ho già sfiorato anche il secondo: gli studi culturali sono un campo in decostruzione.17 Anche i queer studies sono un campo in decostruzione e il pensiero di Liana è, almeno in parte, decostruzionista. Allora ritorno su questo punto, così ritorno anche a Liana e concludo.
Il pensiero di Liana è per me allineato con il decostruzionismo, inteso in senso lato come la capacità di continuare a usare un sistema concettuale pur indicandone i limiti, cioè standone sia dentro che fuori. Forse non Liana non lo ha mai detto apertamente. Infatti ogni volta he le ho rammentato come il ragionamento di Butler sul genere venga da Jacques Derrida e dall’aporia del genere, ogni volta che ho citato di conseguenza
16 A. Panajia et al., Il Libro Azzurro per la riforma delle cure primarie in Italia, Primary Care, settembre 2021, https://www.researchgate.net/publication/355164944_IL_LIBRO_AZZURRO_PER_LA_RIFORMA_D
ELLE_CURE_PRIMARIE_IN_ITALIA.
17
G.C. Spivak (2000) Deconstruction and Cultural Studies: Arguments for a Deconstructive Cultural
Studies, in N. Royle (a cura di) Deconstructions, Palgrave, London.
12
i pensatori decostruzionisti che si mescolano nel mio lavoro (maschi, ahimè, e nemmeno gay: non solo Jacques Derrida, ma anche Gilbert Simondon e Bernard Stiegler) ha sempre fatto finta di guardarmi con orrore. Liana ha sempre chiamato Bernard Stiegler (uno dei più grandi filosofi francesi del ventunesimo secolo che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa) “quel tuo amico”.
Per me, non si può essere queer senza essere decostruzionisti. Il genere, per Butler, è quello che per Derrida è la firma, l’evento impossibile che stabilisce l’origine e l’autenticità. Non c’è e non c’è mai stata una firma originaria, la mia prima firma perfetta a fronte delle quali tutte le mie successive firme possono essere verificate e autenticate. Allo stesso modo, non c’è un genere originario. C’è solo una dichiarazione di genere (“complimenti, care mamme, è una bella femminuccia”) che fa del corpo la copia dell’inesistente corpo originale di una neonata essenzialmente femmina. Poi, per fortuna, è arrivata Karen Barad che (nell’intervento del Prado Liana ne parlava) ha dato una mano a liberare i queer studies del fondamentale fraintendimento di Butler, che sostiene che Butler ignori il corpo. Neanche per sogno, dice Barad. E’ solo che l’osservato non preesiste né l’osservatore né lo strumento di osservazione, il quale a sua volta è un apparato conoscitivo sociotecnico che introduce un “taglio” ontoepistemologico nel continuum della materia. Teorie, concetti e strumenti sono degli assemblaggi umani e tecnici che costituiscono una “lente” attraverso la quale osserviamo l’universo. Ma noi siamo parte dell’universo osservato e ce ne differenziamo solo nel momento in cui ci facciamo lente. Non c’è né un osservatore né un osservato, ma solo la materia che si autodifferenzia costantemente, solo l’universo che in questo processo di autodifferenziazione si rende intelligibile a (una parte di) se stesso. “Oh guarda, qui ci siamo io e una particella”. “Sì, ma è perché si sta usando quello strumento lì. Se si stesse usando invece questo qui, ci saremmo io e un’onda. La particella non ci sarebbe e forse non ci saresti neanche tu”. Questo taglio (il taglio agentivo, l’agential cut), che Barad chiama intra-azione (per significare che non ci sono due entità che inter-agiscono ma due entità che co-emergono nel momento dell’azione), questo “taglio” è sia epistemologico (cognitivo, ci dà a vedere la realtà) sia ontologico (costituisce, crea la realtà). Allo stesso modo, la comunità è aporetica, sostiene Jan-Luc Nancy: a costo di semplificare molto, se voglio la democrazia, devo escludere le forze politiche totalitarie, quindi un sistema democratico si costituisce sempre su un atto di violenza originaria. Questa è l’aporia
13
del genere, l’aporia della firma, l’aporia delle origini, l’aporia della comunità (o la comunità in decostruzione). Ogni sistema concettuale opera un’inevitabile esclusione, deve avere necessariamente un punto cieco che non è pensabile all’interno di quel sistema; altrimenti non si dà, non riesce a esistere. Tendiamo all’esistente, ma siamo sempre “in decostruzione”, instabili. L’unica scelta etica è quella che non oscura la violenza originaria che ci permette di costituirci e di esistere; inevitabile, certo, ma proprio perciò se ne deve dare conto.
Liana riusciva così a tenere insieme molte tensioni. Il punto programmatico, qui, sarebbe quello di nominare le nostre aporie. Nominiamo anche la decostruzione (lo dico da uno spazio di pensiero che mi costituisce anche come marxiana e foucaultiana), perché non è un vecchio impianto concettuale per pensare la letteratura, ma un modo per adoperare i concetti vedendone e indicandone i limiti e standoci dentro ugualmente. Parliamo di aporia, nominiamola, accettiamola, se no ogni volta ci incartiamo in opposizioni impossibili. Perché anche questo è il modo che Liana ci suggerisce per stare “accanto”, per vivere con le tensioni e le instabilità radicali.
Se Liana fosse qui adesso con le modalità di prima, le direi che ho finalmente messo a frutto il pensiero di Butler e Barad in un modo che forse le può piacere. Ci sono voluti solo altri dieci anni. Sto lavorando ancora sui tecnocorpi – e se dovessi enunciare un altro punto programmatico direi che mai come oggi è stato importante studiare i tecnocorpi, da quelli prodotti dalla pandemia a quelli della sorveglianza globale. E improvvisamente, anche e soprattutto grazie a una giovanissima collega femminista di Cambridge, Eleanor Drage, che ha delle intuizioni pazzesche che a Liana piacerebbero tantissimo, improvvisamente mi salta fuori che anche la firma digitale – quella cifra su cui si basa il riconoscimento facciale negli aeroporti, oppure negli smartphone, oppure il riconoscimento delle impronte digitali – è a sua volta una copia senza originale.
Se Liana fosse qui con le modalità del nostro spaziotempo, le porterei le teoriche, filosofe, scienziate, data scientists, giovanissime, femministe e non-bianche che stanno scrivendo libri bellissimi su Intelligenza Artificiale e sessismo, razzismo, classismo e performatività. Forse per una volta avrei letto qualcosa che lei non ha
14
ancora letto (o forse no). Si tratta di Timnit Gebru, Kate Crowford, Ruha Benjmin).18 Siccome con Liana ci siamo incontrate non solo su Haraway e Preciado ma su Hayles e sulla tecnoscienza e sul rapporto tra scienza e letteratura, le racconterei che l’anno scorso sono stata al convegno annuale di 4S (gli studi sociali della scienza e tecnologia, un campo che le interessava molto, il campo con il quale femministe come Evelyn Fox Keller, Lucy Suchman, e la stessa Haraway conversavano quotidianamente) e che ho scoperto che è pieno di studiose femministe nere, e, appunto, giovanissime.
Parleremmo di come ormai sia un fatto conosciuto che i sistemi di Intelligenza Artificiale non siano per nulla obiettivi, che anzi siano razzisti e sessisti. Si tratta dei sistemi che, anche a nostra insaputa, sorvegliano i confini nazionali, scannerizzano i nostri passaporti, decidono se abbiamo diritto alla previdenza sociale, calcolano la probabilità che la nostra faccia sia quella di un criminale o il nostro accento quello di un terrorista. In realtà i programmatori hanno sempre saputo che l’Intelligenza artificiale non è obiettiva, che ha dei pregiudizi. Sono le corporation che vendono questi sistemi come obiettivi, per esempio ci dicono che usando l’intelligenza artificiale per selezionare candidati, le aziende possono eliminare il “bias”, quel modo di pensare che fa sì che i maschi bianchi tendano ad assumere altri maschi bianchi, e si può così ridurre il gender gap e assumere molte più donne (ma ovviamente non è così). Con Liana forse parleremmo di qualche caso eclatante, per esempio di Elaine Owusu, una studentessa nera britannica che nel 2020 ha tentato di usare il sistema di AI dell’HMPO, l’ente britannico per il rilascio dei passaporti, ma questa IA non è stata in grado di riconoscere il suo viso. Questo avviene perché l’AI è fortemente “biased” nei confronti delle donne nere. E’ un sistema che funziona benissimo nel riconoscere le facce dei maschi bianchi. Funziona meno bene nel riconoscere le foto di donne nere o di persone non binarie. E’ quella che Os Keyes, nei suoi studi sulla transfobia dell’intelligenza artificiale, chiama bullshit technology, tecnologia delle stronzate.19
18 Si vedano ad esempio K. Crowford, Atlas of AI, New Haven e Londra, Yale University Press, 2021; R. Benjamin, Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code, Polity, 2019; T. Gebru, “Race and Gender”, in M . D. Dubber, F. Pasquale, S. Das (a cura di) The Oxford Handbook of Ethics of AI, Oxford University Press, 2020.
19 O. Keyes, “Counting the Countless”, Real Life, 2019, https://reallifemag.com/counting-the-countless/.
15
Oppure parleremmo di quando la polizia di Baltimora ha arrestato uno scuolabus pieno di bambini di colore che andavano a scuola perché il loro sistema di polizia predittiva (una AI che scannerizza i social e traccia gli hashtag come “Black Lives Matter”) li aveva erroneamente segnalati come potenziali terroristi.
Ad ogni modo, per quanti sforzi si facciano, non si riesce a fare il de-bias di queste AI, di questo Machine Learning che è composto di complicatissime reti neurali che nessuno riesce a capire, tanta è la loro complessità. Sono agenti tecnologici autonomi capaci di imparare e possiamo solo sottoporli a un training migliore, cercare di esporli a dati di addestramento diversi e “migliori”, sperando che imparino a essere meno razzisti, sessisti e transfobici – ma ancora non ci è riuscito nessuno. L’intelligenza artificiale continua ad agire la sua violenza, a razializzare violentemente i corpi di minoranze oppresse. Probabilmente nessuno è riuscito a estrarre il bias dall’AI perché’ cambiare i dati di training è un metodo bullshit, una stronzata; è soluzionismo tecnico. Non è che bisogna togliere i pregiudizi dall’intelligenza artificiale. E’ che bisognerebbe togliere i pregiudizi dalla società, cioè dall’assemblaggio sociotecnico di cui tutte siamo parte.
A Liana piacerebbe sapere che esiste una teoria, pensata da Louise Amoore, un’altra studiosa femminista, che sostiene che l’AI è performativa, cioè che è appunto un apparato osservatore che “taglia” il mondo nel senso di Barad, e che AI performa il reale insieme con il resto della socio-tecno-umanità, e che siamo tutte parte di questa performatività’, e che infine bisogna ripensare l’etica e la politica dell’AI tendendo conto di questo. Forse le piacerebbe anche sapere che, partendo dalla teoria di Amoore, Eleanor e io abbiamo aggiunto l’idea che, oltre alla performatività osservativa di Barad, anche la performatività citazionale di Butler gioca una parte importante in questo processo. In altre parole, non e’ possibile correggere il razzismo e il sessismo di AI perché’ anche AI, come noi, lavora con copie senza originali: le prima volta che mi registro sul mio nuovo iPhone per attivare il riconoscimento facciale, l’iPhone crea una rappresentazione digitale del mio viso. Poi, ogni volta che l’iPhone mi vede e mi “riconosce”, è come se mi facesse una foto digitale e la confrontasse con l’originale che ha memorizzato. Indovinate? Mi riconosce solo se la nuova foto è simile all’originale memorizzato, ma anche un po’ diversa. Questo si chiama riconoscimento “by proxy”. Funziona così. Il mio iPhone sa che il mio viso non si presenta mai uguale, che e’ l’insieme di infinite micro-variazioni dovute a luce, angolatura, stanchezza,
16
occhiaie. Se per assurdo gli presentassi una copia perfetta del viso che ho registrato la prima volta (una copia perfetta dell’originale), l’iPhone andrebbe in allarme e sospetterebbe una frode. Il che rende il riconoscimento facciale estremamente sicuro, perché una copia perfetta sarebbe sicuramente una simulazione, magari rubata da qualche hacker. Questo processo rende però anche visibile un aspetto importante, e cioè che l’iPhone funziona secondo il principio di Butler: non ci sono originali, solo copie di copie.
La soluzione al bias dell’AI probabilmente non esiste semplicemente perché bisogna cambiare la domanda. Non dobbiamo chiederci come possiamo usare l’IA in modo meno razzista”, ma quali usi e quali compiti non dovrebbero nemmeno esistere (né tantomeno essere lasciati a una IA). Ancora meglio, dovremmo chiederci come possiamo convivere con questi agenti tecno-umani con cui, probabilmente, abbiamo anche sviluppato degli attaccamenti e condividiamo degli affetti. Oppure come possiamo rendere visibili i limiti, i confini, le esclusioni e le invisibilizzazioni che l’AI rende possibili.
Ma Liana non e’ in questa piega spaziotemporale, non ora. Perciò posso soltanto suggerire questi pochi punti. Nominiamo le aporie. Stiamo accanto. Stiamo con la tensione, vediamo fin dove essa è sostenibile e come fare per sostenerla. Non oscuriamo. O meglio, dato che oscurare è inevitabile, puntiamo il dito verso ciò che stiamo oscurando, dichiariamolo, facciamo in modo che qualcuno veda ciò che noi non vediamo. Per farlo bisogna essere in una dimensione collettiva, e questo ci rassicura. Ci sarebbe da preoccuparsi solo se tutte vedessimo la stessa cosa, ma per fortuna ciò è impossibile.
Continuiamo a performare delle cose, delle situazioni, degli interventi. Prima con Marco Pustianaz parlavamo della collana editoriale “Altera”. Anche Altera è performativa. Performa qualcosa, è un intervento, è un taglio nel mondo. L’obiettivo è non nascondere dove facciamo il taglio escludente che ci delinea rispetto al mondo, che ci fa emergere dal mondo. Questo taglio, per fortuna, è sempre, inevitabilmente, già in disfarsi (in decostruzione). Ma questo disfarsi bisogna renderlo visibile. E’ un’operazione difficile, ma non so se abbiamo altra scelta. Liana ci ha portate altrove e ci porterà altrove ancora. L’importante è che continuiamo a “correre” con le sue idee.
17
Tagged on: federica frabetti